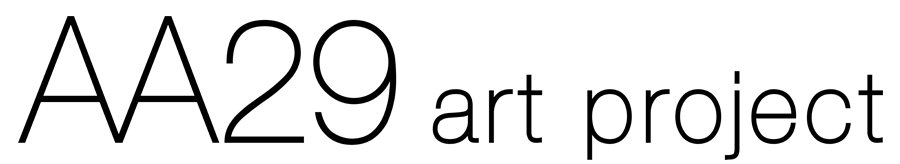On Paradise
Jompet Kuswidananto
Jompet Kuswidananto
Mónos
La serie di Vincenzo Pagliuca mònos nasce da una lunga ricerca che l’artista ha realizzato lungo l’Appenino Meridionale, dal basso Lazio fino all’Aspromonte, fotografando all’alba o in condizioni di luce particolari. L’artista compone l’immagine mettendo le case isolate, che in molti casi non sono più abitate e in cui lo stato di deterioramento e abbandono è evidente, al centro. Sono architetture apparentemente casuali ma in grado di creare relazioni straordinarie con il contesto circostante.
Le condizioni di luce scelte tingono le foto di tonalità tali da veicolare il freddo dell’alba invernale in campagna. L’uniformità della serie, sia dal punto di vista delle tipologie architettoniche, sia dal punto di vista della composizione, rende evidente, quasi in maniera paradossale, le particolarità e unicità di ogni esemplare.
Villa Monteturli
Valentina De Rosa ha lavorato dal 2013 a Firenze in una villa del XV secolo che ospita persone con gravi problemi psichici, motori, e sensoriali. L’artista si è avvicinata a loro per ritrarli uno a uno, su uno sfondo di colori piatti e vividi, in una situazione allo stesso tempo quotidiana e personale, che segue in alcuni casi i tratti stilistici del ritratto classico. De Rosa si rapporta ai soggetti ritratti con uno sguardo empatico ma, come scrive Giovanni Fiorentino, senza nessuna intenzione di denuncia, distanziandosi in questo modo della tradizione del reportage. Le opere trovano un punto di equilibrio nel modo distaccato e allo stesso tempo delicato con cui espongono la fragilità e momentanea calma delle vite delle persone rappresentate.
Teitiota
Le immagini del progetto TEITIOTA appartengono ai miei ricordi personali, in particolare ai momenti in cui l’essenzialità dello stare con e dentro il mondo si svela in tutta la sua magnificenza. Ma è anche uno sguardo che sfugge, che rivela il timore di una precarietà che accende il dubbio sul ‘per sempre’. Un’inquietudine che è diventata più insistente con la nascita sette anni fa del piccolo Ivan, il figlio di mia sorella. Con loro condivido le mie giornate e la mia vita.
Il titolo del progetto è il nome del primo richiedente asilo per cambiamenti climatici. Ioane Teitiota ha chiesto asilo alla Nuova Zelanda dove si era rifugiato con la sua famiglia perché l’arcipelago del Pacifico da cui proviene, Kiribati, è minacciato dalla crescita del livello del mare, e alcuni dei 33 atolli corallini sono già sommersi dall’oceano. Secondo le Nazioni Unite, Kiribati fa parte degli Stati insulari, insieme alle Maldive, Tuvalu e Tokelau, la cui sopravvivenza è minacciata dal cambiamento climatico. Ma la Corte Suprema neozelandese qualche giorno fa ha rifiutato la sua richiesta. Nonostante questo, Teitiota ha aperto una porta verso una nuova consapevolezza. Gli scienziati oggi affermano che continuando di questo passo, se non riusciremo a contenere l’aumento della temperatura entro il tetto massimo di due gradi posto dall’ultimo report dell’IPCC, entro soli dieci anni circa 50 milioni di persone si trasformeranno in “rifugiati climatici” e milioni di animali saranno costretti ad emigrare, o moriranno, così come le piante, a causa di inondazioni, desertificazione, alluvioni, tornado ed uragani, molte aree subiranno modifiche permanenti, e l’intero ecosistema sarà messo a rischio.
Il nostro ruolo di ospiti della terra e la nostra relazione con la natura si trovano in una situazione senza precedenti. Summit internazionali hanno un compito decisivo, a partire dalla COP21 di Parigi sul Cambiamento Climatico. Ma forse ancora più determinante è la moltitudine di decisioni individuali di un’umanità che scavalca i confini dell’antropocentrismo.
Ci dicono che abbiamo un minimo margine di tempo per agire su nuove possibilità. Per aprire la comprensione verso l’esigenza di un sentire inedito, o forse solo dimenticato, e di uno sguardo nitido sull’essenzialità.
Merlana – Casablanca
Questo lavoro è una riflessione sull’impossibilità di smarrirsi in un luogo sconosciuto, poiché dovunque nel mondo incontriamo gli stessi segni e tracce delle multinazionali e del consumismo capitalista e usiamo le stesse modalità digitali per trovare la via. Le foto sono state scattate con cellulari, macchine fotografiche usa e getta e altri strumenti da turista. Le didascalie di luogo e tempo non corrispondono alle immagini reali.
Caution
Quest’immagine fa riferimento ad un cartello molto popolare negli Stati Uniti: un avvertimento di attenzione alle famiglie in fuga dal Messico che attraversano le highway. La stessa fuga vissuta in tempi recenti sulla rotta Balcanica, interrotta dal filo spinato che intrappola animali umani e non umani.
Il cartello ha assunto oggi in California una vita propria, stampato su t-shirts, mugs e altri gadget, come un simpatico souvenir.
In Caution la campitura fiorita offre una dimensione esordiente, che possa accogliere dal grembo del tempo una nuova visione oltre i confini della linearità storica.
Il Dipartimento dei Trasporti della California ha pubblicato diversi “segnali stradali di avvertimento sull’immigrazione familiare” lungo le autostrade a partire dal 1990, quando l’area era un imbuto per immigrati privi di documenti diretti a nord che attraversavano il confine tra Stati Uniti e Messico e dove morivano migliaia di immigrati.
Nel tempo l’immagine del segnale stradale ha assunto una vita propria. Oggi la famiglia che corre si trova su magliette, tazze da caffè, adesivi, copertine di libri e altri gadget, come un souvenir.
Ma la storia recente ha visto le stesse famiglie in fuga attraverso la rotta dei Balcani, interrotta da filo spinato intrappolando animali umani e non umani.
In Caution lo sfondo fiorito offre una dimensione di debutto, che accoglie dal cuore del tempo una nuova visione oltre i confini della linearità storica.
Nohas’ Ark
‘The modern age has been characterized by a Promethean spirit, a restless energy that preys on speed records and shortcuts, unmindful of the past, uncaring of the future, existing only for the moment and the quick fix… Lost in a sea of perpetual technological transition, modern man and woman find themselves increasingly alienated from the ecological choreography of the planet.’
Jeremy Rifkin
It is a Noah’s Ark made of newspaper articles of the day of its creation. It welcomes watering cans-animals that carry the water of life as opposed to the water of death of the great flood.
“L’era moderna è caratterizzata da uno spirito prometeico, da un’energia irrequieta in preda a traguardi veloci e scorciatoie, dimentica del passato, incurante del futuro, esistente solo per il singolo momento e la soluzione rapida…L’uomo e la donna moderrni, persi in un mare di perenne transizione tecnologica, sono sempre più alienati dall’ecologica coreografia del pianeta.”
Jeremy Rifkin
L’installazione è stata realizzata con le pagine di alcuni quotidiani usciti il giorno della sua creazione, e accoglie al suo interno coppie di annaffiatoi-animali: l’acqua della vita contrapposta all’acqua della morte del Diluvio Universale.
September Baroque
September Baroque
SEPTEMBER BAROQUE (dopo W. Benjamin)
2009-2013, serie di fotografie: stampa lambda montata su dibond.
“Non vi è documento di civiltà che non sia, allo stesso tempo, documento di barbarie”. Walter Benjamin (Tesi di Filosofia della Storia, 1940)
September Baroque è un lavoro collegato al progetto Pandora e Ahimsa.
Ritrae Tor, un puro cavallo Lipizzano che ho salvato dal macello.
Il primo allevamento di cavalli Lipizzani ebbe origine nella cittadina di Lipizza nel 1580, grazie all’Arciduca Carlo d’Austria, per procurare i cavalli alla nobiltà asburgica di corte. La Lipizzana è una razza di cavalli strettamente associata alla Scuola di Equitazione spagnola di Vienna, dove s’insegnava l’ “haut école” o la “scuola superiore” di dressage classico, incluso l’alto controllo, i salti scolastici e altri movimenti conosciuti come “le arie sopra il suolo”. Alla Scuola di Equitazione spagnola i cavalli vengono ancora preparati usando i metodi tradizionali che risalgono a centinaia di anni fa, basati sul principio del “dressage” classico.
Cavalli molto simili venivano tipicamente rappresentati in scultura e nei monumenti equestri del diciassettesimo secolo.
“Il lavoro della memoria fa collassare il tempo.” W. Benjamin
Tor, un cavallo in ottima salute e docile, allenato al dressage nella vecchia scuola di Lipizza, era comunque destinato a essere macellato.
L’uso della fotografia in questa serie è deviato: io ho alterato le ottime qualità della foto fino all’estremo, al momento dell’istantanea. Così le immagini, scattate in un giorno pieno di sole, sembrano quasi notturne e hanno un effetto piuttosto pittorico.
Art History è una tappa fondamentale della ricerca e della vita dell’artista. È una pratica che consiste nello scambiare un dipinto con un essere senziente che stava per essere macellato: per esempio un cavallo, un asino, un coniglio, un agnello, un pollo, un maiale, una capra, a seconda del progetto.
È un atto effettivo che permette di salvare una vita attraverso il mezzo artistico, senza l’impiego di denaro e che rappresenta una questione aperta, allo stesso tempo, sul valore della vita e dell’arte.
Inoltre ci fa domandare: può l’arte salvare davvero una vita?
Il progetto comprende un’azione giorno per giorno, dei contratti, una serie di fotografie (stampa a getto d’inchiostro su carta metallica, montata su plexiglass), dei disegni (grafite su tela e grafite su carta) e dei dipinti (olio e grafite su tela).
2008, serie fotografica: stampa lambda su carta metallica montata su plexiglass.
Questo progetto è parte del Premio Pictet_Water, video slide show, presentato al Palais de Tokyo (Paris) nel 2008 da Kofi Annan (premio Nobel per la Pace nel 2001, insieme alle Nazioni Unite).
Durante il mio lungo viaggio in Africa ho scoperto con dispiacere l’attualità dell’espressione idiomatica “civilizzazione bianca”, nitidamente descritta da Joseph Conrad.
Stone Town, la capitale dello Zanzibar, è stata il più importante mercato di schiavi della costa orientale dell’Africa. Le sue rive sono state per secoli il punto di partenza della tratta degli schiavi.
L’egemonia dei paesi industrializzati sta condannando l’intero pianeta. Ed è un fatto che colpisce, in primis, i così denominati paesi in via di sviluppo, che a causa di ciò corrono dei seri rischi. L’Africa contemporanea non ha assunto un ruolo effettivo nella questione del riscaldamento globale, un problema che invece è stato causato dall’attività economica dei paesi industrializzati quali gli Stati Uniti d’America.
Bagamoyo significa in Kiswahili “Qui io lascio il mio cuore”. È il nome dell’ultima città africana che i prigionieri vedevano prima di imbarcarsi per Zanzibar e da lì per altri continenti o, più probabilmente, per morire.
I See You
Tiziana Pers nell’ambito della mostra Marinella Senatore. Costruire Comunità, allestito nella Manica Lunga del Castello di Rivoli il 19 dicembre 2013 ha effettuato una performance intitolata I see you nello spazio Movie Set.
L’ospitalità assoluta esige che io apra la mia dimora e che la offra non soltanto allo straniero (provvisto di un cognome, di uno statuto sociale di straniero, eccetera), ma all’altro assoluto, sconosciuto, anonimo, e che gli dia luogo, che lo lasci venire, che lo lasci arrivare e aver luogo nel luogo che gli offro, senza chiedergli né reciprocità (l’entrata in un patto) e neppure il suo nome.
Jacques Derrida
Durante l’azione performativa, la Pers, una forte e statuaria artista friulana, accompagnata da un gruppo di bambini, si collega via skype con Cometa, un’asinella salvata da un commerciante che stava per mandarla al macello. I bambini sono invitati a dialogare con l’asina, leggendo delle frasi, selezionate dall’artista e stampate su fogli sparsi a terra, oppure a parlare direttamente con Cometa che, in un luogo protetto sulle colline friulane, segue con interesse quello che succede sullo schermo mentre mangia una carota.
L’empatia tra i cuccioli di umano e l’animale non umano è scattata immediatamente. Tiziana ha spiegato loro che Cometa è stata salvata dal macello e che, grazie a loro che in quel momento si trovano lì, continuerà a vivere. Non a caso, pur sapendo che Cometa è stata salvata grazie alle generose donazioni e al lavoro degli attivisti, Tiziana ha detto loro: “Cometa è viva grazie a voi”, estendendo ai bambini il concetto di partecipazione e di azione individuale.
Alcuni bambini hanno pianto, alcuni hanno raccontato delle storie, altri hanno ascoltato, ma non c’è stato nessuno che non abbia partecipato, provando, se ce ne fosse bisogno, che in un certo momento della vita di un futuro uomo o di una futura donna, in un veloce, transitorio momento, c’è la possibilità di ‘porre ascolto‘ all’altro animale, quello non umano.
Nella sua pratica artistica, Tiziana applica la formula del baratto a un animale destinato alla macellazione che verrà scambiato con un’opera. La sua arte si fa moneta di scambio, ma il prezzo dell’opera non viene quantificato in una somma di denaro, bensì con una vera vita. In apparenza si tratta di un’operazione piuttosto semplice, che sottrae l’animale e l’opera agli usuali meccanismi del mondo dell’arte e dell’allevamento rispettivamente mentre, al tempo stesso, si interroga contemporaneamente sul valore dell’arte, e su quello della vita. Il senso profondo di questa operazione è però oltre, in ciò che rimane, nel risultato: l’animale, quell’animale, è vivo.
È un processo non scevro da molti dubbi e quesiti e per molti versi provocatorio, ma sembra davvero uno dei primi tentativi concreti di far incontrare l’arte e il mondo animale su un livello nuovo, timidamente permeato di antispecismo, in un’era, la nostra, che può essere considerata come la preistoria dei diritti animali.
Mi pare interessante riportare che, nei luoghi di dolore dove transita per la sua pratica artistica, Tiziana non sceglie mai l’animale da portare via, ma chiede al mercante di prenderne uno a caso. Quei momenti, racconta, sono occasioni di grande sofferenza e l’unico modo di metabolizzare questo dolore è la pratica artistica che, di rimando, utilizza per veicolare questo dolore e per continuare a salvare delle vite non umane.
Oltre alla vita dell’animale, al momento effimero della performance, seguono dipinti nei quali l’artista focalizza il suo sguardo sullo sguardo animale, secondo due modalità. In primis, Tiziana esplora anatomicamente le pupille animali che contengono lo sguardo, facendo emergere la soggettività degli esseri che ritrae: gli occhi vitrei dei conigli da laboratorio sono differenti da quelli guizzanti del suo amato cavallo Tor. In secondo luogo, Tiziana dipinge lo sguardo facendosi lei stessa animale e ritraendo l’altro da sé fuori dagli stereotipi che per secoli hanno caratterizzato la rappresentazione animale.
Gli animali di Tiziana sono liberi da gabbie fisiche ma, soprattutto, dalle gabbie invisibili che la nostra immaginazione ha costruito loro attorno.
Valentina Sonzogni
Rive Bianche
2010, installazione site-specific: dipinti (olio su tela), disegni (grafite su tela), chiodi, stampa lambda su carta metallica montata su plexiglass, inchiostro su muro.
Muro dell’autorità, Vecchia Stazione della Polizia, Londra
“Zanzibar fu uno dei mercati di schiavi più importanti della costa orientale dell’Africa. I corvi venivano portati a Zanzibar per mangiarsi i corpi degli schiavi che venivano gettati in mare all’inizio del XIX secolo.
I corvi rimanevano sulle rive”.
AHIMSA (La Messa a Santa Cristina), 2013, serie di stampe a getto d’inchiostro montate su dibond e serie di stampe a getto d’inchiostro su carta cotone, installazione site-specific e video.
“Solo per chi non ha più speranza, ci è data la speranza.” Walter Benjamin
Ahimsa è un antico termine sanscrito che significa “non fare del male” (letteralmente: rifiutare la violenza – himsa).
È un importante principio religioso che si è originato nell’antica India. Ahimsa è una modalità di comportamento che proibisce l’uccidere o il fare del male agli esseri viventi. È strettamente connesso con la nozione che tutti i tipi di violenza implicano delle conseguenze negative sul karma. Nei tempi moderni Mohandas Karamchand Gandhi ha promosso il principio dell’ahimsa con molto successo, applicandolo a tutte le sfere della vita, in modo particolare alla politica.
Ho salvato questo cavallo dal macello, durante la mia gravidanza. Così ho scritto AHIMSA sul suo fianco.
La fotografia ritrae una vera e propria Messa (26 maggio, 2013) che ha avuto luogo nella chiesa barocca di Santa Cristina a Parma.
L’immagine, stampata su tessuto e raffigurante il fianco dipinto del cavallo, è stata appesa sull’altare, al posto della Croce.
AHIMSA, maggio 2013, stampa a getto d’inchiostro, su carta cotone.
Installazione site-specific, Chiesa di Santa Cristina, durante una Messa in onore della morte di Don Gallo, Parma.
Mutabis
Vinci/Galesi: la tessitura emozionale di un percorso
di Eleonora Raspi
“Sono i luoghi che ispirano il movimento, che ti fanno fare un tragitto, che ti trasportano attraverso le cose, che ti creano delle prospettive diverse, sono quelli che “spaziano” attraverso di te e che, viceversa, ti permettono di fare luogo a un concetto, un’idea, un pensiero. Facendoli diventare spazio.” Giuliana Bruno
Fiore contro fiore, erba contro erba, elemento naturale contro elemento naturale. Due corpi si muovono lentamente su un terreno scosceso, tra i sassi di una fabbrica abbandonata, tra le pietre di un deposito minerario, nel fango di un prato fiorito. La luce crea ombre sul mantello cangiante in movimento, il corpo del performer porta con sé suoni contrastanti ma continui; infine si ferma, e diventa un tutt’uno con l’immobilità apparente della natura. D’improvviso il buio, i fiori si chiudono su loro stessi, lo sguardo del performer lascia trapelare un pensiero di fine.
MUTABIS è un progetto che comprende un ciclo di opere-performance, ideate dal duo artistico Vinci/Galesi. Una metamorfosi in fieri, a carattere universale, capace di adattarsi ed entrare in sintonia con ogni luogo prescelto. La particolarità del progetto risiede nella capacità di rapportarsi con più media espressivi: dalla performance al video, dalla fotografia al suono, dalla scultura al disegno. Ogni medium esplora e mette l’accento su un aspetto di MUTABIS.
Il primo atto è stato presentato da Vinci/Galesi in occasione della manifestazione d’arte contemporanea ALTER, nella città di Chiaramonte Gulfi il 31 luglio 2015. Gli artisti, avvolti da un mantello infiorato, viaggiavano per diverse ore lungo le vie, per le piazze e tra gli spazi monumentali della città, concludendo la performance all’interno della Chiesa di Santa Teresa con un ultimo momento di trasfigurazione, un abbraccio in cui le due entità diventavano un tutt’uno. Per questo secondo atto, Vinci e Galesi scelgono il luogo dei ricordi, della memoria, dell’infanzia; l’11 marzo 2016 MUTABIS attraversa Scicli e si apre alla collaborazione e allo sguardo registico di Alessandro Zangirolami, e alla sperimentazione sonora del sound maker Antonio Mainenti. Qui MUTABIS diventa un cammino itinerante lungo tre giorni che si allontana dal centro urbano e vissuto quotidianamente, e va a toccare, a percepire e ascoltare altri luoghi, ovvero spazi non frequentati dal grande pubblico e resi invisibili dal tempo.
MUTABIS è trasfigurazione del corpo in elemento naturale; unione di due entità in un’unica e sola. Il performer si veste o, ancora più propriamente, si investe di un abito fiorito, un habitus proveniente dal mondo naturale di cui si erge portatore. Con il procedere dell’atto creativo, viene meno la distanza tra il corpo e il sentire umano e il corpo e il sentire della natura; la corruzione della carne diventa un tutt’uno con la corruzione dei fiori del mantello. Quella che tradizionalmente è concepita come una dicotomia, in MUTABIS diventa un’unione di voci.
Il viaggio attraverso sei location (una interna e cinque esterne) è parte integrante non solo della storia e delle leggende della comunità siciliana, ma anche della storia personale dei due artisti. Lungo tutto il percorso, l’occhio della camera afferra i corpi degli artisti, seguendoli ora da lontano – fino al momento della loro scomparsa nella natura – ora da vicino, quasi a sfiorarne i fiori, oltrepassarli, e infine penetrarne la carne. Il suono originato, sensibile ai mutamenti della luce, ora accompagna, ora fa da guida, modulandosi a seconda dei movimenti e delle emozioni.
È un rapporto aptico quello che la camera instaura con Vinci/Galesi che a sua volta rispecchia quello che loro instaurano con i luoghi che attraversano. Secondo la ricercatrice italiana Giuliana Bruno (Harvard University), il concetto di aptico prevede la presenza di un rapporto tattile, fisico, con lo spazio, che va oltre la semplice visione. I due artisti, attraverso il loro peregrinare e osservare, entrano in contatto con lo spazio, seguendo una logica non più oppositiva, ma inclusiva. Attraverso l’accostamento dei fiori del mantello alle superfici, vanno a curare una ferita decennale: il fiore – la presenza dell’elemento naturale in generale – è riparatorio nel loro lavoro, simbolo di rinascita e flusso energetico. Contenitore di una memoria millenaria, il fiore si fa carico delle mancanze dell’uomo e porta omaggio là dove c’è abbandono e negligenza morale. Terra che ritorna alla terra, fiore che ritorna alla pianta, corpo che ritorna all’origine del suo essere.
L’ex Mulino San Niccolò, cuore dell’impegno intellettuale, politico e sociale dei due artisti, è il primo luogo scelto e contemporaneamente unica location interna oggetto di indagine della performance. Si snoda in passaggi da un angolo all’altro, abbassamenti sul terreno e sguardi incrociati, e si tramuta infine in abbraccio – apice della trasformazione in unico corpo nel quale maschile/femminile e uomo/natura si confondono. Vinci/Galesi si muovono lentamente nello spazio, osservandone le vertebre, le nervature portanti, gli spigoli e le imperfezioni del corpo architettonico.
Ad ogni movimento, apertura e chiusura, il suono risponde; ora più tenue, ora più presente, diventa la voce di quella microtensione così carnale dei gesti e dei fiori. Durante il tragitto di Vinci/Galesi, i rumori e le armonie della natura si accordano e risuonano con/contro una partitura sintetica spontanea, generata dai fotosensori indossati dai performer. Vibrazioni di sapore elettronico, che quasi sembrano appartenere ad una sfera ultraterrena o ad un linguaggio lontano dall’umano, esplodono dal corpo di risonanza del performer e si liberano nell’aria man mano che il cammino procede. È un circolo vizioso, un inseguirsi; è il suono stesso, scaturito prima dal corpo dell’artista, a guidare ogni suo movimento successivo. E da elemento indigeno degli spazi attraversati e della stessa terra che li accoglie, il performer intraprende un processo di estraniamento per poter vedere da “lontano”, in uno stato di verginità, ciò che sfugge allo sguardo quotidiano.
Il rituale, i suoni, gli sguardi, si ripetono negli altri cinque luoghi scelti: l’ex Fornace Penna in contrada Pisciotto, la Cava di pietra adiacente all’antico Convento della Croce, la Cava di argilla di Truncafila, la pietraia in contrada Giarberi e infine un campo fiorito in contrada Cuturi. Ogni volta, ad ogni passaggio e scambio di energia, qualche petalo o intero fiore si stacca, quasi a lasciare una testimonianza della propria presenza e doloroso dialogo con il territorio. Se da un lato il passaggio dentro uno spazio e tra gli spazi influenza la percezione di sé stessi e dei luoghi attraversati, dall’altro lascia inevitabilmente una traccia fisica ed emozionale di questo incontro, sia sul soggetto che sulle superfici attraversate. Come un tessuto che si modella sul corpo di chi lo indossa, Bruno ci descrive il rapporto tra spazio e soggetto come legame carnale bidirezionale. Performers e spettatori si trovano immersi nel luogo del “tra”, dove e-mozionarsi (muoversi fuori) e com-muoversi (viaggiare insieme), dove il viaggio, tra esterno e interno, privato e pubblico, potenzia la loro sorpresa ed emozione.
I Viaggiatori Indossavano Il Fuoco Della Bellezza
“I viaggiatori indossavano il fuoco della bellezza”, è un’opera in cui la “carne” dei due artisti fiorisce di un rituale antico. I volti, si fanno infatti ciechi di fiori, mentre nel dischiudersi dei petali scompaiono sguardi e tratti somatici alla ricerca di un’ibridazione (im)possibile. Con il recupero di un gesto manuale antico, quale il ricamo con fiori, si attua una metamorfosi in cui senso del sacro e identità individuali vengono proiettati altrove. Nella tradizione sciclitana della Cavalcata di San Giuseppe, i ‘bardatori’ intessono le gualdrappe dei cavalli con fiori veri onorando il passaggio della Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto. Astraendo la ripetizione del ricamo floreale, il gesto si reitera non più sui drappi degli animali ma sulla pelle dei due artisti, l’immagine (performativa) non appartiene più alla sfera religiosa ma si fa icona di un viaggio nella disgregazione del sé: l’incontro con ciò che sta al di fuori e al contempo al di dentro dell’individuo, nell’opportunità di una congiunzione tra natura e cultura. Il duo Vinci/Galesi presenta una nuova performance, riportando alla presenza degli spettatori la fisicità dell’azione dove il limite tra corpo umano e corpo non umano non è più percepibile. La ricerca dell’altro avviene tramite la lentezza del gesto: la vista è negata, e il rapporto, sinestetico e faticoso con la moltitudine di fiori, diventa la chiave di lettura di un vissuto comune ancora da scrivere.
Cosa Vedi?
“Il paesaggio è un terreno di gioco totale che, percepito, percorso, pensato, diventa per l’intelligenza tecnica, linguistica e sociale un modello schematico imprescindibile”
Matteo Meschiari
Dall’alba al tramonto gli artisti Vinci/Galesi hanno affrontato un viaggio in tutta Scicli per chiedere COSA VEDI?
IL VIAGGIO
Gli artisti Sasha Vinci e Maria Grazia Galesi – indossando una wearable sculpture, ovvero un copricapo in ferro adornato di fiori – hanno viaggiato nello spazio urbano di Scicli, nel corso di tutta l’intera giornata del 17 marzo per osservare un mondo fatto di voci, sguardi, dialetti, usanze, strade, monumenti, piazze ed ancora colori, odori ed emozioni.
Hanno riletto il passato ed il presente della loro città natia, rivisitando luoghi cari e storici, rivolgendosi a ricordi d’infanzia, attraversando chiese, edifici pubblici, monumenti e paesaggi, chiedendo alla società presente “COSA VEDI?”. Una domanda diretta e spontanea, spiazzante e imprevista che forse vuole incitare ad aprire gli occhi, vuole incoraggiare la gente a “vedere”, osservare meglio quello che si ha attorno, le bellezze che ci circondano, ma anche le disarmonie che sostituiscono il nostro presente. Una domanda che forse vuole fare riflettere sui problemi sociali e politici che, come a Scicli, attraversano anche le altre città; o forse qualcosa di più ampio che sfocia in un discorso ontologico e generico: “cosa vedi adesso del presente?”, “cosa vedi adesso nel nostro tempo, nel tempo in cui viviamo?”.
All’imbrunire, i due artisti hanno concluso la performance ricomponendo le due wearable sculpture con l’installazione site specific primaria: uno stendardo in colore cremisi – colore ufficiale della cittadina – adornato di fiori e realizzato con l’impronta del corpo degli artisti. Simbolicamente l’essenza, l’identità della persona si congiunge con il corpo/stendardo che è basamento, sede dove le identità si poggiano e in unione formano la collettività.
WEARABLE SCULPTURE
Come una maschera o un copricapo, la wearable sculpture (letteralmente “scultura da indossare”) rivela molteplici identità. Una struttura in ferro adornata da fiori, applicati con la stessa tecnica utilizzata per bardare i cavalli della tradizionale cavalcata o “infiorata” di San Giuseppe.
L’opera rappresenta l’unione, un cubo sormontato da una piramide a base quadrata, due figure geometriche che si legano per descrivere uno spazio intimo che accoglie, la “casa” in cui nascono le diversità. Metaforicamente è un simbolo ascensionale: la torre che sale all’assalto del cielo, immagine della montagna cosmica, riferimento al valore della collettività.
COSA VEDI?
Cosa intendono gli artisti con questa domanda? Vogliono forse sapere cosa la gente osserva individualmente ogni giorno nel mondo o nella propria città? O semplicemente si riferiscono alla loro performance? Il viaggio diventa un momento nel quale la gente, spiazzata dalla repentina ed inaspettata domanda “COSA VEDI?”, viene interrogata nell’intimo, viene toccato il quotidiano di ogni persona.
Martina Tolaro
Foto
Luca Migliore
Silvia Sammito
Video
Daniele Cascone
La Terra Dei Fiori
Armati di petali
Daniele Capra
Il progetto La terra dei fiori, di Sasha Vinci e Maria Grazia Galesi propone una contro-mitologia rispetto ai luoghi della Campania che sono stati al centro delle cronache giudiziarie degli ultimi anni per le tragiche questioni ambientali e criminali. Luoghi che hanno visto cedere alla malavita la completa gestione del territorio, luoghi in cui lo Stato ha abdicato e i cittadini hanno convenuto di essere assenti, di non vedere o non sapere, prigionieri volontari dell’indifferenza cui in pochi hanno saputo resistere. Essere cittadini implica però schierarsi e non mettere la testa sotto la sabbia, come aveva spiegato proprio un secolo fa Gramsci, in un tagliente monito morale: “Odio gli indifferenti. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. […] Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita pone loro quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto” .
La terra dei fuochi è disseminata di scorie tossiche, è avvelenata, insalubre, è vinta dagli eventi tragici che l’hanno colpita. È un dedalo attorcigliato come in una tragedia greca in cui gli dèi puniscono gli uomini per la loro superbia, per la tracotanza dell’hýbris di coloro che hanno mancato di rispettare l’ordine necessario.
A questa impasse Vinci/Galesi suggeriscono invece una via di uscita, di ordine visivo e morale, attraverso una contro-narrazione territoriale, a partire dai fiori che in Campania sono coltivati. Al degrado essi contrappongono infatti il rigoglioso germogliare della natura, che è elemento di meraviglia ed espressione della volontaria ricerca di riscatto della cittadinanza. Il territorio campano può essere infatti anche la terra dei fiori, luogo in cui crescono gerbere e crisantemi. Nostra deve essere la volontà di invertire lo stato delle cose, nostra la spinta mirata al superamento della situazione attuale. L’arte che si propone anche di cambiare il mondo deve suggerire una percorribile pratica di salvezza. E, forse, anche dall’estremo abbandono possono germinare onestà, bellezza, dignità. Ma se, e solo se, si pensa che una soluzione a portata di mano sia praticabile.
Nelle cultura visiva occidentale il fiore è in maniera indissolubile legato alla bellezza, alla purezza, agli elementi transitori e alla caducità. Da quando si afferma definitivamente il tema iconografico dell’annunciazione, quasi ogni arcangelo che si presenti alla Madonna reca tra le mani un giglio, fiore che non è solo, insieme alle ali, uno degli attributi identificativi di Gabriele, ma anche un segno di buon auspicio e soprattutto un simbolo che fa riferimento alla purezza della Vergine. E pullulano di fiori, con una ricchezza di varietà botaniche ancor maggiore, in particolare dal secondo Quattrocento, i prati che circondano scene sacre o mitologiche, in cui sono evidenti i riferimenti alla bellezza, al ciclo delle stagioni, alla rinascita.
Il fiore reciso è inoltre uno degli elementi caratterizzanti di un genere come la natura morta, che si diffonde a partire dalla fine del Cinquecento e che diventa uno dei soggetti più praticati dalla pittura fiamminga del Secolo d’Oro. È l’allegoria della bellezza e della fugacità del mondo insieme, ma anche un campo di battaglia per le fantasie e le virtuosistiche abilità pittoriche degli artisti: è decorazione e insieme un monito, laico e realistico, frutto di una società che si sta secolarizzando e che vuole commissionare agli artisti non solo scene religiose o mitologiche, ma opere che raccontino e parlino del mondo a loro contemporaneo.
Nel Novecento delle avanguardie che passano al tritacarne ogni topos iconografico ed ogni rigidità socio-culturale, il fiore, dopo esser stato prevedibilissimo soggetto pittorico decorativo comune negli interni borghesi, perde completamente le sue caratteristiche per esser metafora di altro: in particolare della donna, dell’eros oppure, con una complessità psicologica maggiore, dell’inganno celato dalla seduzione dell’apparenza. Ma nella seconda metà degli anni Sessanta, una vera rivoluzione avviene coi movimenti studenteschi e la controcultura hippie. Allen Ginsberg teorizza in un articolo infatti come “masse di fiori – in una sorta di spettacolo visivo – specialmente concentrate sulle linee frontali possano essere usate per per creare delle barricate” . Nasce così il Flower power e l’idea di rispondere con un fiore alla violenza e alla forza dell’autorità, irridendo polizia ed esercito con un gesto infinitesimamente piccolo di protesta: ai soldati schierati si offre infatti un fiore o lo si infila dentro la canna dei loro fucili. Da quel momento il fiore è qualcosa di diverso, è strumento di una lotta pacifica, l’emblema di una stagione di non-violenza con cui manifestare la contrarietà sia alla guerra in Vietnam che ad una politica che conosce l’uso delle armi come solo strumento di risoluzione dei conflitti tra gli Stati.
Il progetto La terra dei fiori mostra ed argomenta le possibilità espressive del fiore – segno di rigenerazione e spiritualità – ma soprattutto lo rende un dispositivo politico che l’arte impiega in forma simbolica. Non vi sono in esso questioni manifestamente ideologiche, quanto invece ragioni concettuali e botaniche: condivide gli stessi terreni delle aree inquinate, ma produce bellezza, e con delicatezza suggerisce la possibilità di cambiamento dello status quo.
Vinci/Galesi propongono visioni transitorie, fuggevoli quanto la bellezza di un fiore, meraviglia condannata ad un veloce disfacimento. In queste opere l’elemento floreale trasforma, anima, nasconde. È una presenza naturale che racchiude molteplici significati che affondano le radici nelle mitologie più antiche. Ma sono anche metafora della fragilità del mondo contemporaneo, immagine di gioia e di lutto. Dell’eros che anima l’amore terreno e della pace che scioglie quello celeste.
La serie de La terra dei fiori è costituita da opere fotografiche di grandi dimensione, un neon di color magenta che icasticamente ripropone il titolo del progetto, dei mattoni realizzati impastando la terra dei fuochi e poi dei disegni e della documentazione. Tali lavori raccontano il percorso attraverso cui Vinci/Galesi hanno interrogato, grazie all’impiego del fiore, le identità individuali ma anche i luoghi dimenticati segnati da abbandono, trascuratezza, degrado civile.
La terra dei fiori suggerisce, in maniera simbolica, le potenzialità mimetiche e metamorfiche insite nell’elemento floreale, che vengono dagli artisti portate al massimo grado. La bellezza semplice di gerbere e crisantemi incarna infatti la reazione allo sfacelo di un territorio soggiogato dalla criminalità e dall’inquinamento causato dai rifiuti. È metafora del possibile ribaltamento della forzosa circostanza di prigionia, è il sogno di ribellione ad una situazione a cui, razionalmente, non si sarebbe potuto immaginare una via d’uscita percorribile.
I due artisti si mostrano interamente avvolti da un mantello floreale coloratissimo che nasconde i tratti somatici in contesti dal valore simbolico. La loro figura è quella di un spirito che dissemina colore e futuro nel grigio e nell’abbandono del presente. Il drappo in cui gli artisti sono avvolti è realizzato cucendo a mano migliaia e migliaia di fiori su eterei tessuti, rispettando un’antica tradizione propria delle celebrazioni religiose della festa di San Giuseppe di Scicli, nel ragusano. Gli scenari sono invece quelli poetici di una spiaggia in cui mare e terra si contendono la supremazia; ma quella è soprattutto la riva in cui sono sbarcati decine di disperati provenienti dall’altra sponda del Mediterraneo, in fuga dalla guerra, luogo in cui si sono arenati corpi di uomini senza più speranza. La bellezza dei luoghi, testimoniata da alcune immagini degli ultimi progetti, è così un controcanto che fa stridere ancor più i limiti della condizione umana.
La terra dei fiori. Note per una rinascita
Gabi Scardi
Il progetto La terra dei fiori del duo Sasha Vinci e Maria Grazia Galesi è una grande metafora. Una metafora che nasce da una necessità sentita, e che si innesta su modalità, contenuti e relazioni sedimentati nell’arco di anni. Il progetto si nutre di una serie di convergenze.
Coerentemente con l’impostazione performativa del lavoro di dei due artisti, l’aspetto scenico è fondamentale; il progetto prende anzitutto la forma di una coreografia articolata in più tempi: una sorta di rituale, e come ogni rituale, La terra dei fiori si nega a ogni univoca decodifica; vive in parte di una propria evidenza, ed esprime un’energia, una forza vitale, quasi magica. Ma non solo.
Tutto avviene in due aree: la cittadina siciliana di Scicli e il suo territorio, e la terra dei fuochi, in Campania. Anche se il riferimento è a una storia molto più grande. Vinci/Galesi si concentrano su luoghi connotati da una estrema teatralità. Tra questi compare l’antica Chiesa di San Matteo, la Mater Ecclesiae che splendidamente sovrasta Scicli dall’alto. Dopo un periodo di degrado l’edificio fu restaurato; solo per essere nuovamente abbandonato: una vicenda di incuria tristemente emblematica.
C’è inoltre la costa di Sampieri, sempre nei pressi di Scicli, con la sua magnifica spiaggia; una spiaggia che è gioia dei bagnanti, ma che ci appare ben più aspra se pensiamo che è anche punto di approdo di tanti migranti, e per alcuni di loro tragico fine-viaggio. E non è un caso che per la messa in scena della loro performance i due artisti abbiano scelto l’imbrunire: una decisione che conferisce alle immagini un effetto intimo, onirico, enigmatico; che contrasta però con il motivo della scelta; l’orario è quello dello spiaggiamento di tredici migranti avvenuto a Sampieri il 30 settembre 2013.
Infine la grandiosa Reggia di Caserta, sede della mostra e, in occasione dell’inaugurazione, della performance. Un edificio che si imponeva un tempo sulla fertile e splendida Campania felix. Oggi ai suoi piedi si stende il territorio devastato della terra dei fuochi; un’area la cui condizione è paradigmatica di un rapporto tra il territorio e i suoi abitanti basato sull’arroganza, sullo sfruttamento e sull’illegalità.
Gli elementi fondamentali del progetto sono dedotti da un rituale tuttora in uso a Scicli: l’Infiorata di San Giuseppe; un rituale che Sasha Vinci e Maria Grazia Galesi sentono non solo nella dimensione esteriore, ma come modello attraverso il quale dare forma e significato alle relazioni interpersonali e al sentire collettivo. Perché il rito, come l’arte, è anche modalità di conoscenza, ricerca di senso, e ambito creativo in cui il singolo e la collettività si esprimono. Non solo; oltre a rispecchiare e sancire condizioni sociali, relazioni interpersonali e abitudini mentali, l’azione rituale parte dal presupposto che il rito possa contribuire attivamente a crearle.
L’azione di La terra dei fiori fa ricorso a simboli primari: i fiori, anzitutto, ricorrenti nel progetto sotto diverse forme. Con i fiori gli artisti creano una serie di poliedri, simboli antichi di equilibrio e di conoscenza, presenti sin dall’antichità nel pensiero occidentale; e realizzano due cappe con cui si coprono, fino a oscurare completamente le proprie singole personalità; così celati allo sguardo, cercano di instaurare una rinnovata relazione con il contesto. Con un terzo manto, infine, bardano lo stallone nero frisone, Eros, protagonista dell’Infiorata di Scicli.
I fiori sono da sempre simbolo di vita e di bellezza. Ma Vinci/Galesi hanno scelto di utilizzare crisantemini e gerbere: fiori che vengono coltivati intensivamente in entrambe le aree di riferimento del progetto, e che in Italia sono associati alla situazione del lutto. Il riferimento è dunque tanto alla morte e ai rituali che la accompagnano, quanto alla violenza delle logiche di un profitto cieco e ai suoi mortiferi effetti sull’ambiente.
Ha un ruolo centrale nel progetto il cavallo, magnifico compagno della loro avventura, figura iconica e monumentale, espressione di fierezza, di forza vitale, di sensibilità; e simbolo di un necessario rapporto di rispetto tra l’uomo e le altre creature. Alla sua figura i due artisti affidano il momento culminante del loro intervento, con il corteo infiorato del cavallo e dei bardatori che avanza sul viale rettilineo, verso la scalinata della Reggia.
Vinci/Galesi hanno inoltre realizzato, in inchiostri naturali e pigmenti, una serie di disegni. E sempre manipolando con tecnica antica la terra, più precisamente la terra di Acerra, hanno dato forma ad alcuni mattoni che portano incisa la parola “Felix”.
Così, alle forze distruttive che sembrano essere riuscite ad impadronirsi dei comportamenti e dei pensieri e che hanno determinato la devastazione ambientale del territorio siciliano, di quello campano, e per estensione di molte aree del villaggio globale, gli artisti oppongono l’elemento costruttivo per eccellenza, il modulo di base di ogni edificare: il mattone; sul quale incidono la memoria – e la speranza – di un equilibrio possibile, avanzando così la nozione di un passato che fu diverso e di un possibile futuro.
Alla mancanza di riguardo e al collasso morale che queste due aree d’Italia testimoniano, i due artisti rispondono contrapponendo la memoria collettiva e culturale trasmessa dalla sapienza artigianale e recuperando l’idea di relazioni basate sulla cura e sul rispetto. Del resto, già nel suo essere un progetto a quattro mani, La terra dei fiori porta con sé un senso di condivisione.
Nel lavoro emergono dunque le grandi dicotomie: natura e cultura, umano e animale, vita e morte, visibile e invisibile, rapporto con il proprio habitat, o sfruttamento. La terra dei fiori è un modo di confrontarsi con il tempo presente, calandosi nelle relazioni e nei rapporti di potere. Di parlare di valori, disvalori, di degrado e di una potenziale rinascita; è un modo di reagire all’arroganza opponendole la forza vitale, l’aspirazione, il desiderio.
Quando Le Mani Furono Liberate
Installato a VIR Open Studio 5 luglio 2018
Lavoro composto da:
Due monitor, un lettore di mani, un riflessologo
Carichi di simbolismo, i lavori su carta di Sasha Vinci ritraggono uccelli, insetti, solidi platonici, uomini e donne che percorrono temi non ancora superati, nel tentativo di costruire una relazione che vada oltre i vincoli della natura e le strutture di dominio sociali ed economiche: dal sessismo all’omofobia, dal rapporto dell’uomo con la natura alla connessione con il corpo, proprio e altrui.
Le forti cromie sono ottenute da materie naturali, e si concentrano e diluiscono sullo svolgersi delle immagini, tratte soprattutto da riviste d’epoca e da fatti di cronaca degli ultimi giorni presi dal web. A corpi umani, animali e forme geometriche viene riservata la medesima cura, in un resoconto che in prospettiva ricerca nelle vicende trascorse le radici dei fatti di oggi, delineando nella fluidità del colore la morbidezza di uno sguardo differente e possibile. Uccelli implumi gridano dal fondo del nido, mentre la sentinella-cardellino veglia, erta su un Solido Platonico: origine della materia e parte del tutto.
Le prime femen si accostano a pugni alzati alle guardie che anticiparono le SS, nell’ucronia di un incontro. La morte di Pasolini si intreccia con le prima manifestazioni per i diritti omosessuali, mentre farfalle multicolori si posano su vicende tese tra passato e futuro.
Carichi di simbolismo, i lavori su carta di Sasha Vinci ritraggono uccelli, insetti, solidi platonici, uomini e donne che percorrono temi non ancora superati, nel tentativo di costruire una relazione che vada oltre i vincoli della natura e le strutture di dominio sociali ed economiche: dal sessismo all’omofobia, dal rapporto dell’uomo con la natura alla connessione con il corpo, proprio e altrui.
Le forti cromie sono ottenute da materie naturali, e si concentrano e diluiscono sullo svolgersi delle immagini, tratte soprattutto da riviste d’epoca e da fatti di cronaca degli ultimi giorni presi dal web. A corpi umani, animali e forme geometriche viene riservata la medesima cura, in un resoconto che in prospettiva ricerca nelle vicende trascorse le radici dei fatti di oggi, delineando nella fluidità del colore la morbidezza di uno sguardo differente e possibile.
Uccelli implumi gridano dal fondo del nido, mentre la sentinella-cardellino veglia, erta su un Solido Platonico: origine della materia e parte del tutto. Le prime femen si accostano a pugni alzati alle guardie che anticiparono le SS, nell’ucronia di un incontro. La morte di Pasolini si intreccia con le prima manifestazioni per i diritti omosessuali, mentre farfalle multicolori si posano su vicende tese tra passato e futuro.
NON SI DISEGNA IL CIELO – Chiaramonte Gulfi Canto II è il canto della città di Chiaramonte Gulfi, definita il Balcone di Sicilia per la sua mirabile posizione panoramica.
A Chiaramonte Gulfi Sasha Vinci rivolge il suo sguardo al cielo per creare un’opera che diventa il canto delle stelle. La panoramica celeste del cielo stellato visibile da Chiaramonte Gulfi nella notte del 1 agosto 2015, alle ore 24:00, viene ribaltata ed incisa su un disco di ferro retro illuminato simbolo della Terra. La luce che filtra dalle incisioni a sua volta si riflette sulla volta della Chiesa di Santa Teresa, luogo in cui è installata l’opera, disegnando e restituendo le costellazioni al cielo. Nell’opera Cielo e Terra diventano un unico elemento.
Seguendo il simbolismo del Circolo delle quinte, è stata composta un’armonia suonata da più strumenti che rappresenta un’istantanea della “voce” delle stelle, corpi celesti che evocano negli esseri mistero e bellezza.
La nota scelta per inaugurare il Canto è il FA, che nella simbologia musicale del circolo delle quinte rappresenta l’alba della musica. Il tempo della partitura è 4/4, poiché il 4 nella simbologia numerica è considerato il primo vero numero.
La melodia di NON SI DISEGNA IL CIELO – Chiaramonte Gulfi Canto II è stata creata in collaborazione con il musicista e compositore Vincent Migliorisi. Foto di Giuseppe Giordano e Alberto Trovato.
NON SI DISEGNA IL CIELO – Volterra Canto I è il canto del paesaggio terreno e celeste della città di Volterra.
Dall’alto della torre di Palazzo dei Priori, sede storica del comune toscano, l’occhio dell’artista Sasha Vinci scruta l’orizzonte e, compiendo un movimento circolare di 360°, realizza una panoramica fotografica che delinea lo skyline naturale della città di Volterra, linea di confine tra la terra e il cielo. Il tracciato ottenuto viene riportato in un pentagramma, dove attraversando il rigo musicale definisce delle note, creando così un andamento sonoro che diventa il canto della natura, la voce del paesaggio della città di Volterra.
Alla melodia generata vengono apportate solo delle leggere alterazioni. La nota scelta per inaugurare il Canto è il FA, che nella simbologia musicale del circolo delle quinte rappresenta l’alba della musica. Il tempo della partitura è 4/4, poiché il 4 nella simbologia numerica è considerato il primo vero numero. Nasce così un tracciato sonoro che diventa andamento ritmico generato dalla natura stessa. È la pietra che canta, è la misteriosa bellezza di un paesaggio mutevole, romantico e malinconico. Il suono creato rappresenta un’istantanea della “voce” della terra, poiché il paesaggio si trasforma, è un elemento cangiante che muta col passare del tempo, essendo soggetto a diverse alterazioni causate dall’uomo, o dall’erosione naturale degli agenti atmosferici.
NON SI DISEGNA IL CIELO – Volterra Canto I, non si conclude con il canto del paesaggio, ma si evolve e si completa con una installazione site specific, in cui le linee dello skyline vengono riportate ed incise su 21 lastre di alabastro (ciascuna 15 x 25 x 1,5 cm).
L’alabastro è un materiale che racchiude ed esprime l’identità storica della città che vola, famoso per la sua lucentezza e trasparenza. Nell’installazione Sasha Vinci sceglie di retro illuminare l’opera, lasciando emergere lo skyline inciso in un cosmo di colori e venature. L’opera, composta da una melodia e da un pentagramma in alabastro, è stata installata all’interno dell’atrio di Palazzo dei Priori, il più antico palazzo comunale toscano, un luogo che si erge a simbolo della vita civile, sociale e politica della comunità.
La melodia di NON SI DISEGNA IL CIELO – Volterra Canto I è stata realizzata in collaborazione con il musicista e compositore Vincent Migliorisi. Foto di Alessandro Zangirolami.
… se qui per “realtà” si intende la kantiana cosa in sé, la Ding an sich che, in quanto distinta dal fenomeno (testualmente: Erscheinung, “apparizione”), è per definizione preclusa alla conoscenza da parte del soggetto, il quale non può fare altro che limitarsi alla Ding für mich, cioè alla “cosa per me”, la cosa che mi appare, ciò che vedo e che tuttavia non coincide con la realtà noumenica, poiché quest’ultima può solo venire pensata. Ma stando così le cose, vorrebbe forse dire che l’opera di Sasha Vinci il suo messaggio – perché di messaggio manifestamente verbale si tratta, dunque almeno in questo caso nomina sunt consequentia rerum – debbano giocarsi all’interno di una problematica gnoseologica di derivazione kantiana? Non necessariamente, anche perché lo scollamento tra le percezioni del soggetto e la realtà esterna indipendente da esse non è affatto tema inedito nella riflessione filosofica moderna; almeno da quando questa, con Cartesio, ha aperto lo iato che separa la realtà dalle immagini che di essa si hanno. L’intento dell’opera di Sasha Vinci non è allora la riproposizione di una vexata quaestio epistemologica (peraltro risolta già a suo tempo dall’idealismo), quanto piuttosto la definizione di una sua ben precisa curvatura etica.
Prendendola abbastanza alla larga, è singolare come in una lingua naturale come l’italiano (ma ciò interessa anche altre idiomi) il campo semantico della visione coincida in molti punti con quello del pensare, dell’opinare, del credere o del comprendere: “contemplare” significa sia pensare in raccoglimento che osservare rapiti dalla bellezza di qualcosa, “la visione del mondo” è una particolare comprensione di esso, “essere dell’avviso” (dal latino visum, riconducibile a video) significa avere un particolare parere, l’espressione “non vedo perché” non significa altro che “non capisco perché”; come d’altronde “aver frainteso o travisato la realtà” equivale all’”averne un’immagine distorta”. Del resto i greci, i quali oltre ad essere noti per lo zoon politikon hanno anche tracciato per primi i connotati dell’homo videns, chiamavano “idea” e “immagine” con lo stesso nome (idea,eidos) e ritenevano che vedere e pensare fossero fondamentalmente la stessa attività, dal momento che nominavano entrambe con il medesimo termine di theorein, teorizzare ma anche e soprattutto theos-horao, visione del perfetto cioè del vero.
Che significa dunque alla luce di tutto ciò (ancora una coincidenza di visione e comprensione!) “Quello che vedo non è la realtà”? Plausibilmente, che in un epoca mediale di vuoti simulacri, di appiattimento della profondità ermeneutica (Jameson) e di fruizione consumistica delle immagini (nonché dei relativi, sottesi messaggi) il dubbio cartesiano o la critica kantiana dovrebbero essere trasferiti su un piano non più epistemologico (dato che della realtà fisica fuori di noi o della genuinità delle nostre percezioni di essa non v’è più motivo di dubitare), bensì etico. Detto in altri termini: il motto/opera di Sasha Vinci vuole far riflettere (cioè pensare e contemporaneamente rifrangere luce) sullo scollamento stabilitosi da una parte tra l’appiattita, quando non ideologicamente falsata, immagine del mondo veicolata dall’enorme e invadente apparato dei media, dell’industria culturale e dell’informazione (la quale per un artista visionario/creativo come Buñuel era da intendersi come uno dei quattro cavalieri dell’Apocalisse), e dall’altra quella che ancora dovrebbe essere recuperata come realtà, la quale però sembra ritrarsi sempre più lontana, sommersa da immagini inautentiche che hanno tradito l’originario, nobile mandato di farsi latrici di realtà e di verità.
Per questo motivo Sasha Vinci, in concomitanza alla Giornata del Contemporaneo promossa dalla AMACI, vorrebbe ripristinare il principio (in un questa accezione etica spesso dimenticato dalla contemporaneità) di estrema vicinanza, quasi identità, tra il vedere e il comprendere; lo fa paradossalmente, cioè attraverso la sua manifesta violazione; ma “Quello che vedo non è la realtà” potrebbe venire parafrasato in: “Ciò che vedi dovrebbe essere anche ciò che comprendi, dunque il vero; ma se non riesci a scorgere verità dietro ciò che vedi, allora l’immagine è falsata; e dunque per vedere/comprendere la realtà hai bisogno di altre, vere immagini”. Si tratta dunque di un appello al recupero del dimenticato valore euristico dell’immagine, funzione le cui vestigia sono ravvisabili sporadicamente sia negli usi della lingua che, molto più sistematicamente, nello strenuo tentativo dell’arte (quando essa vi riesca) di veicolare verità visive o visioni veritiere; ecco allora che dietro la critica o il rifiuto della mistificazione visiva a cui noi tutti siamo soggetti nella nostra quotidianità (“Quello che vedo non può essere la realtà”) si fa strada il tentativo di recuperare l’antico senso unitario dello theorein, il quale benché di antica estrazione è ancora attualissimo principio in un mondo contemporaneo che ha diviso la verità etica dell’immagine dal suo appiattimento a bene di consumo e la verità del mondo dalla menzogna che l’ha occultata.
Giovanni Tidona